
Padre Prosperino Gallipoli da Montescaglioso:
un caterpillar in Mozambico
di fra Francesco Monticchio
da libro: DALLA PARTE DEGLI ULTIMI – PADRE PROSPERINO IN MOZAMBICO
a cura di ENRICO LUZZATI – Silvio Zamorani Editore – 2009
(1)
18 agosto 1971
Quando arrivai all’aeroporto di Quelimane, capoluogo della regione della
Zambézia, (al centro del Mozambico) fra Prosperino Gallipoli da Montescaglioso,
o semplicemente “Pro”, non c’era.
Lo avevo conosciuto in Italia qualche anno prima. Era venuto in ferie e aveva
avuto un incontro con noi studenti di teologia.
Mi aveva fatto uno strano effetto quel missionario. La comunicazione immediata,
la gioia con cui trasmetteva le sue esperienze, il fatto di sentirsi “speranza”
per la gente con cui lavorava mi sembravano qualcosa di esagerato.
Era un momento in cui tra noi frati non si teneva in grande considerazione
la possibilità di investire la propria vita nella missione. Negli ultimi 10 anni
erano partiti solo due missionari. La missione la si pensava e la si riteneva un
impegno di seconda categoria. Io ero uno di quelli, così non prendevo troppo
sul serio Pro quando cercava di coinvolgere tutti sulla bellezza e ricchezza di
vivere la propria vita in una “cultura altra”, di annunziare Cristo salvatore e
stimolo nuovo per ogni popolo, lingua e cultura.
Ma non potevo sottrarmi al fascino che suscitava in me ciò che lui faceva e
il modo con cui operava in Mozambico. C’era in lui qualcosa di “speciale” che
gli altri missionari, pur sempre eroi, non avevano.
Il nomignolo “Pro” deriva dalla firma con cui egli chiudeva il foglietto ciclostilato
Azione missionaria pensato, scritto, redatto, commentato solo da lui e
spedito molto irregolarmente ai frati/confratelli che vivevano in Puglia. Forse
tra le carte vecchie dell’archivio provinciale se ne potrebbe trovare qualche copia.
Quel nomignolo a noi ragazzi faceva l’effetto di un certo che di eroico, come
una avventura spirituale, esotica.
Ma il ricordo di quell’incontro mi rimase dentro.
Ecco perché, arrivato a Quelimane, anche io missionario come lui, me lo
aspettavo all’aeroporto.
Non c’era.

Il primo approccio
Il primo vero incontro con lui avvenne a Luabo, una cittadina industriale,
sede della Sena Sugar Estates, sul fiume Zambezi e a 70 Km dalla sua foce.
Era la mia prima missione. Quel giorno noi giovani missionari (eravamo
sette), ci eravamo dato appuntamento per discutere sul rinnovamento del quadro
dirigente della missione che sarebbe avvenuto dopo qualche settimana e
per mettere a punto un programma nuovo per la missione. Avevamo chiamato
a parteciparvi Pro, unico missionario della vecchia guardia, perché ritenuto
all’altezza del nostro “complotto”.
Nel pomeriggio un frate della mia missione aveva organizzato una partita
di calcio con una squadra di una popolazione chiamata Perira; aveva caricato i
ragazzi sulla jeep e aveva iniziato a fare le solite manovre per uscire di casa sotto
la guida di Pro che, indicando la direzione della retromarcia, indietreggiava
e a un certo punto, senza sapere come, rimase incastrato tra la sua jeep e quella
che trasportava i ragazzi. Si fratturò il femore. Rimase quindi qualche giorno con noi.
Nonostante la sua sofferenza, si cantava la nostra gioventù, la nostra speranza,
la voglia di vivere e di essere presenti in quel territorio (colonia portoghese
dal giorno in cui Vasco da Gama approdò col poeta Luis de Camões
sull’isola del Mozambico) insieme a un popolo sofferente che aspirava alla indipendenza
politica.
Ascoltavo da lui storie di soprusi, avventure vissute con i coloni portoghesi
e con la gente mozambicana; stimoli da lui suscitati nel cuore della gente
perché non accettasse una situazione di secolare sudditanza, reagisse allo “status
quo”, per far sentire che qualcosa poteva cambiare. «Essere colonizzati –
diceva – non è degno di un popolo. Anche i portoghesi devono rendersi conto
che un popolo non può dominare un altro popolo. Il missionario deve essere
coscienza critica, deve essere chiesa per tutti».
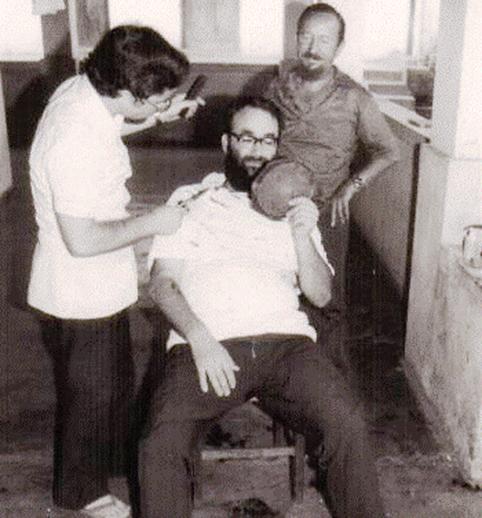
Ascoltavo ancora le storie di una chiesa ancorata alla mentalità preconciliare.
Un episcopato che non aveva ancora assorbito le nuove spinte trasformatrici
venute dal Concilio Vaticano II che avevano fecondato la società
europea e spinto venti di rinnovamento e trasformazione dell’uomo.
In Mozambico non era ancora possibile pregare e predicare nelle lingue
bantu e solo il portoghese era veicolo dell’annuncio evangelico. «Parlare la lingua
locale bantu – diceva Prosperino – era come aprire lo scrigno della ricchezza
di un popolo».

Tra un canto goliardico e l’altro, in uso in Italia a cavallo tra gli anni
Sessanta e Settanta, ci raccontava quanto aveva dovuto lottare per poter aprire
la prima scuola secondaria in una missione, la sua, quella di Morrumbala, distretto
localizzato nel cuore della Zambézia. Dal governatore al vescovo, tutti
giudicavano poco “prudente” aprire una scuola secondaria per soli neri. Ma il
suo saper fare e la sua ricerca dialettica di “ragioni” per convincere ed agire lo
aiutarono ad aggirare l’ostacolo. Egli convinse tutti i coloni bianchi (piccoli
commercianti sparsi per il mato – foresta – di Morrumbala, medio-piccoli agricoltori
ed allevatori, in ogni caso una vera rete economica capace di produrre
e commercializzare per sé e per gli altri, di far girare prodotti e denaro) della
necessità di chiedere per i propri figli l’istituzione di una scuola secondaria in
un posto vicino alla loro residenza. Solo così ottenne l’autorizzazione ad aprire
in missione una scuola ed una casa dello studente, dove ragazzi e ragazze, neri
e bianchi, frequentavano lo stesso istituto, condividevano la stessa mensa, vivevano
insieme il tempo del gioco e del riposo.

Mi accorsi allora della sua ilarità, della sua capacità di ritorno alle origini,
alla storia della sua famiglia, di suo nonno Giuseppe (che voleva fare di lui un
impresario… e perciò si opponeva a lasciarlo entrare nel seminario cappuccino
nel 1943 … e qui una delle sue risate!) col quale era cresciuto dopo la morte di
suo padre, Prospero Gallipoli. Questi a 19 anni era emigrato in America e,
tornato a Montescaglioso, si era sposato con Marietta Tonini. Dal loro matrimonio
nacquero 5 figli: Lillina, (con cui fra Prosperino ebbe sempre un rapporto
privilegiato) Rocco Luigi (Prosperino da frate), Giuseppe, Anna e Donato.
La famiglia aveva un eccellente esercizio commerciale (allora cantina) di vini
e liquori. Alla morte del padre, nel 1938, quando Prosperino aveva solo 6
anni, tutta la famiglia fu accolta dal nonno materno, Giuseppe Tonini, che aveva
un mulino e un servizio di autobus.

I Tonini erano arrivati a Montescaglioso provenienti da Monopoli, in provincia
di Bari, dove Filippo Tonini, garibaldino umbro, si era fermato. Giuseppe
Tonini si sposò con Maria Basilio dalla quale ebbe due figlie, Carmela e
Marietta, mamma di Prosperino.
La famiglia Tonini era molto vicina ai frati: erano francescani secolari! Anche
la mamma di Prosperino frequentava il convento e, lavorando e gestendo il
mulino del padre, era solita offrire molti prodotti ai frati, con i quali aveva
grande familiarità.
Anche i frati dei conventi vicini e lontani andavano al mulino dei Tonini
per rifornirsi di viveri durante la guerra. E nonno Tonini fu sempre molto generoso
e, non raramente, corse qualche rischio per eludere la vigilanza del dazio.
Egli morì nel 1948, quando Prosperino era già in convento.
Con lo stesso tono scanzonato e ironico, Pro raccontava le storie della sua
giovinezza in seminario, dei tiri mancini che giocava a i suoi compagni e superiori,
dei rischi continui che correva di essere rimandato a casa e della stima
che nutriva nei confronti dei suoi formatori e dei frati che gli avevano dato
quanto potevano.
Suonava la fisarmonica, (allora diventava un artista!) cantava con noi:
Quant’è belle lu primo amore, O bella ciao, Quel mazzolin di fiori, Dimmi come
ti chiami, Sant’Antonio allu desertu e tanti altri ancora.
Ma in quei momenti di riposo forzato, si rifletteva anche sul come essere
missionari, sul senso dell’annunzio di Cristo capace di mettere in marcia
l’uomo su ogni cammino di sviluppo, di autocoscienza e di crescita umana; su
come essere missionari cappuccini non solo individualmente ma in quanto
gruppo, in quanto fratelli convocati e mandati a testimoniare Cristo, in quanto
piccola chiesa che annunzia le nuove relazioni di solidarietà e di condivisione
delle proprie ricchezze.
Furono i giorni in cui capimmo che Prosperino poteva interpretare al meglio
le nuove prospettive conciliari e metterle nel grande alveo dell’esperienza
missionaria accumulata lungo gli anni.

Pro, superiore regolare della missione cappuccina della Zambézia
Al capitolo del 1971, Pro fu eletto Superiore Regolare della missione.
Sotto la sua guida i missionari tracciarono le linee di una nuova evangelizzazione
come risposta ai bisogni reali della gente, come proposta a stimolare le
energie più recondite della cultura, come elaborazione delle spinte umane e
spirituali che Cristo propone con la sua vita e la sua parola.
Non più una catechesi teorica venuta dall’alto, ma una evangelizzazione
che prima di tutto impegna il missionario a conoscere la lingua, le tradizioni
religiose, culturali e sociali del popolo; a “farsi” uno del popolo per assumerne
i valori e portarli al pieno sviluppo attraverso il messaggio evangelico.
La prima conseguenza di queste scelte fu che gli ultimi tre frati arrivati in
missione dovettero dedicarsi allo studio di una lingua locale, una delle tante
lingue bantu che si parlano nell’area della missione della Zambézia Inferiore:
fra Francesco Monticchio a Inhangoma e fra Benito De Caro a Chemba per
studiare il Chisena; fra Camillo Campanella a Mocuba per studiare il Etxuabo.
A me Prosperino chiese di stare qualche giorno con lui a Quelimane per
organizzare l’archivio della missione: fu un grande regalo per me, perché ebbi
occasione di conoscere meglio lui e la storia della missione attraverso i documenti
conservati in archivio.

Un giorno successe un imprevisto. Venne da Morrumbala Padre Cherubino
Schiavone da Rutigliano per sbrigare delle faccende. La sua jeep ebbe una
avaria, ma lui doveva necessariamente rientrare. Pro mi chiese di accompagnarlo
a Morrumbala e di ritornare nella stessa giornata. Era il mio primo
giorno di guida in Mozambico!
L’andata fu facile, ma al ritorno infilai una strada diversa e andai in
tutt’altra direzione, perdendomi nella foresta. Arrivata la sera presi una buca, si
spensero le luci, andai fuori pista e la corsa finì in un fossato.
Mi assalì la paura di passare la notte da solo nella jeep. Chiusi i finestrini…
mentre mi sentivo circondato da leoni che annusavano la macchina. Nel silenzio
più cupo della foresta e nel frastuono più sonoro delle mie paure, mi sento
salutare: «Buona notte!». Non riesco a soffocare un grido disperato. «Padre
non gridare – mi dissero quattro uomini – siamo noi. Tu non sei Padre Carlo
Patano da Triggiano, ma noi conosciamo il rumore di questa jeep. È quella di
Padre Carlo. Come mai ce la hai tu? Siamo venuti ad aiutarti!». Informati dell’accaduto,
mi dissero di stare tranquillo e di aspettare sereno il loro ritorno.
Passarono due ore e io non contavo più sulla loro promessa.
Ed eccoli invece arrivare con un piatto fumante di riso, una gallina arrostita
al peperoncino e una coperta. «Padre, mangia qualcosa! Copriti e dormi. Domani
mattina appena spunta il sole verremo e ti tireremo fuori dal fossato». E
se ne andarono via.
Tutta la notte la passai a pensare: «Ma che gente è questa? Sono così i mozambicani?
Mi avevano detto ben altre cose!...».
La mattina sul far dell’alba vennero dieci uomini e tante donne con i loro
bambini. Una festa.

«Mwakhuta? Mwadokerwa?», mi chiesero, e cioè: «Hai mangiato? Hai dormito
bene?».
Ammirazione e confusione, la mia. Ma se non mi conoscevano! ... Solo
perché avevano riconosciuto il rumore della jeep del loro padre Carlo, tanta
attenzione, benevolenza e ospitalità. Me la cavai come potetti. Ma le due
prime parole di chisena erano entrate nel cuore.
Presero di peso la jeep la misero sulla strada, una spinta salutare, la jeep
partì, mi fermai per guardarmeli tutti negli occhi … «Takhuta! Tinaonana
ndziko inango!» E cioè: grazie, arrivederci.
Io non li rividi più. Ma qualcosa era successo in me. È stato un evento che
ha segnato la mia vita e le mie relazioni con la gente.
Qualche ora più tardi arrivai a Quelimane. Pro mi aspettava impaziente
sulla porta. Era nervoso e un po’ pentito per la fiducia che mi aveva dato. Gli
raccontai la mia avventura. E quando cominciai a dirgli dell’aiuto gratuito di
quella gente, si rasserenò. Si tranquillizzò. «Ora conosci il sapore della ospitalità
africana. Non dimenticare mai il regalo che ti hanno fatto: le parole della
loro lingua e i gesti del loro cuore».
In quel momento avevo imparato in che mondo ero approdato. La mia vita
si era riempita di nuove dimensioni. Pro conosceva il sapore di certe cose.
Dopo una decina di giorni di duro lavoro e di studio della grammatica Chi58
sena, lingua che Pro parlava molto speditamente, avemmo tempo e occasione
per fare un viaggio insieme nel territorio della nostra missione. Tre giorni in
giro con una jeep sgangherata: non aveva motorino di avviamento e non aveva
il clakson.
Questo era sostituito da un trombetta che io dovevo suonare ogni volta che
dovevamo sorpassare un altro mezzo. E se il camion non rallentava per lasciarci
passare: «Suona più forte!», gridava lui (nel frastuono immenso della carrozzeria
della nostra jeep e del mezzo che ci precedeva che, in ogni caso, a parer suo,
era sempre più del nostro!) aggiungendo qualche imprecazione per la polvere
che ci toccava inghiottire!
Il motorino di avviamento era tranquillamente sostituito dalla necessaria
spinta a mano per la partenza. Roba da missionari!
Nei momenti liberi da queste operazioni si ripassava la grammatica della
lingua chisena: classi, suffissi, prefissi, pronomi personali e possessivi, verbi,
pronomi …

Lo studio era intercalato da racconti, fatti e storie della missione; dai
progetti di Prosperino per un rinnovamento della vita fraterna e delle relazioni
tra i cappuccini. A suo giudizio tutto si sarebbe potuto risolvere con la creazione
di un fondo comune e la programmazione di progetti e opere da realizzare
in ogni missione. Il fondo comune avrebbe raccolto tutte le entrate e da esso
ognuno avrebbe potuto attingere secondo le proprie necessità. La programmazione
dei progetti delle missioni avrebbe favorito lo sviluppo organico di ognuna
di esse, secondo una scaletta di interventi scaglionati nel tempo.
Tutto ciò per vivere le dimensioni profonde degli ideali cristiani e francescani
della povertà cappuccina nella condivisione dei beni; della fraternità come
un venirsi incontro tra i frati più capaci di reperire fondi e quelli meno capaci;
della testimonianza di vita cristiana come fraternità e non solo come singolo;
della libertà da certi impegni materiali che avrebbero rubato tempo
all’urgenza dell’annuncio evangelico e alla necessaria preghiera.
Le giornate di viaggio passavano con una tabella di marcia veramente spartana:
« Oggi andiamo a dormire a Mocuba… Oggi andiamo a Chire… Oggi a
Morrumbala… Domani a Mopeia…». L’importante era arrivare in una missione
per dormire perché, diceva lui in chisena con un proverbio applicandolo
al contrario alla nostra situazione: mwanamphawi anafuna pyakudya, panagona
ananyeredzera gwekha! E cioè: l’orfano ha bisogno del cibo, il luogo per dormire
se lo cerca da solo.
E mi impressionava questa sua voglia di arrivare da tutte le parti, essere presente
per dare la sua spinta, per infondere coraggio, per stimolare anche con
parole e modi “duri” ma efficaci.
Alle mie osservazioni sulla sua irruenza oppure sulla “ingenuità” di certi
suoi interventi, rispondeva così: «Quando il mozambicano ha capito che gli
vuoi bene e che non chiudi mai il cuore alla comprensione, alla condivisione,
all’ascolto, all’andargli incontro in certe emergenze in cui si viene a trovare…
puoi essere duro come lo sono io. Tu oggi non puoi farlo e forse ti scandalizzi
di certi miei comportamenti, ma io sono qui da 13 anni e ho avuto la gioia-fortuna
di essere entrato nel cuore della gente. Essa stessa mi concede di essere
forte nello spingerli avanti e, senza rinnegare la propria cultura, accettare quanto
di buono io o tu possiamo offrire della nostra maniera di essere…».

Si camminava continuamente. Le tappe si facevano presso le scuole dove
Prosperino controllava il funzionamento, se il professore era al suo posto e se
gli alunni erano numerosi. Parole di fuoco sulla necessità di studiare e una meta
da raggiungere: i migliori alunni sarebbero andati a frequentare la scuola secondaria
di Morrumbala.
Altre tappe erano i piccoli negozi dei portoghesi sparsi ai bordi delle strade
dove trovava i suoi amici e i genitori dei ragazzi che studiavamo a Morrumbala,
nella sua missione. Una birra fresca o un pranzo fugace presso questi amici
e quindi si riprendeva a camminare.
Altre volte la pausa pranzo era più lunga. Quando il professore, o il catechista,
ci invitava a mangiare da lui, i tempi erano più lunghi e le operazioni di
preparazione del pranzo più complicate.
La moglie del professore cominciava a sbucciare il riso nel pilão (pestello), il
figlio più piccolo correva dietro alla gallina di turno che ci avrebbe rimesso le
penne.
«Qui il tempo si ferma, – diceva – ma vedi con quanta generosità la gente
dona quanto possiede!».
Nel frattempo le lunghe chiacchierate sull’andamento della stagione, sul
raccolto, sulla vendita delle eccedenze, sui prezzi applicati dai commercianti
portoghesi, sulle storie del villaggio, le comunicazioni sullo stato di salute e le
malattie di altri amici… Finché non arrivava un bel piatto di riso candido e
fumante e una gallina arrostita al piri-piri (peperoncino)!

Mi faceva impressione quel suo chiacchierare di tutto, di tutti, con tutti.
Era facile per lui trovare il filo giusto della conversazione con i portoghesi che
generalmente si lamentavano dei neri e con i mozambicani amareggiati, umiliati
e offesi dai comportamenti dei bianchi. A questi chiedeva collaborazione
per assumere gli alunni neri durante le ferie per far guadagnare loro il gruzzoletto
necessario per libri e quaderni; ai neri raccomandava di imparare dai
bianchi la conduzione di un piccolo negozio e la capacità a destreggiarsi in
quel mondo così diverso dal loro.
Dopo qualche giorno andammo a Inhangoma, una missione oltre il fiume
Chire, nella regione di Tete, a 80 km da Morrumbala. Mi impressionò il rapporto
franco, maturo, fraterno di Pro con le suore di questa missione, come se
avesse vissuto sempre con loro. Mi affidò a loro per 5 mesi con l’obbiettivo di
studiare la lingua Chisena. Volle vedere il luogo del mio “deserto” spirituale,
lontano dalla missione, immerso in un villaggio. Avevo per me una stanzetta di
4x4x2,5 metri. Il catechista Lorenzo avrebbe provveduto ai miei bisogni e spostamenti,
sua moglie Veronica al mio vitto.
Al momento di salutarci mi disse: «Ti funzioneranno solo occhi, orecchi e… cuore!».
E se ne andò.
E il “deserto-silenzio” fu davvero grande!

A febbraio mi ammalai. Era la malaria, ma io non sapevo cosa fosse. Le
suore mi curarono amorevolmente. Quando il tam-tam arrivò a Pro, egli venne
a prendermi.
«Mwacerwa?»,chiese. «Ndacherwa, penombo imwe!», risposi. (E cioè: stai
bene? Sto bene, non so tu!)
Ci guardammo: io con gli occhi di “eroe” ferito e lui con quelli del “magnanimo”
benefattore!
«Ora hai avuto il battesimo dell’Africa, – disse – ormai il chisena non è rumore
ma suono melodioso per i tuoi orecchi e pieno di significati nuovi per il
cuore! Il silenzio delle parole della bocca ti ha fatto parlare il linguaggio del
cuore; l’inoperosità e l’impotenza ti hanno consentito di scoprire il linguaggio
dello sguardo affettivo e la malaria ha temprato il tuo corpo! Ormai ti sei immerso!
Hai ricevuto il classico battesimo africano!».
(Accidenti, mi dicevo, anche lui ha vissuto le mie stesse sensazioni! Eppure
non sono proprio come lui!)
Un lungo grazie della durata di un giorno alle suore e andammo via!
Ancora una lunga sgroppata. Una tappa alla missione di Morrumbala, la
“sua” missione.
A mano a mano che ci avvicinavamo, diventava meno comunicativo, oscuro,
scontroso… come se qualcosa gli mancasse o avesse il triste presentimento
che qualcosa non procedesse secondo i suoi progetti o, ancora di più, come se
stesse andando verso qualcosa che aveva perduto, che non era più sua!
«Fra Fortunato perde tempo! – diceva quasi tra sé e sé – Non mi interessa
l’estetica, c’è bisogno di efficienza!».
«Ma lo dice proprio di fra Fortunato! Non lo conosce!», dicevo dentro di me.
Ma Pro era così! Non sopportava i tentativi di adattamento di un nuovo
missionario, quasi che dovesse sapere da subito quanto sapeva lui dopo tredici
anni di missione!
Pro realizzava l’essenziale: l’importante era produrre! Far funzionare tutto al
meglio col minimo delle strutture. Non che non apprezzasse il perfezionamento
di quanto si stava realizzando, ma gli interessava altro e chi non faceva questo
“altro”, a suo parere, perdeva tempo e perciò lo definiva “poeta”!
La missione era stata costruita dal Padre Edoardo Guastadisegni da Bari; le
costruzioni si snodavano ordinate e solenni. Questo frate di disordinato aveva
solo il cognome, ma era un bravo architetto urbanista.

Quando arrivò il ciclone fra Prosperino Gallipoli da Montescaglioso, la
missione crebbe in fretta, abbozzata. Il non-finito era visibile in ogni casa, in
ogni progetto e nella planimetria generale: segheria di qua, a destra il forno,
falegnameria di là, sotto il mulino, a sinistra il pronto soccorso, sopra la casa
dello studente; di là, presso le suore, la casa delle studentesse; qua vicino
l’officina meccanica; là, lontano dai motori, la scuola media; al centro, il refettorio
degli studenti; davanti, giù, affianco alla strada, il campo di calcio…
Ci volle infatti la pazienza di fra Fortunato Simone da Rutigliano e di fra Fedele
Bartolomeo da Cirigliano per rendere vivibile e ameno l’ambiente della missione
di Morrumbala costruita sul bel colle dello Ntendere (colle della pace).
L’umore cambiava e riprendeva il suo solito parlare quando si arrivava ai
punti nevralgici del percorso della sua missione: ecco la scuola centrale di Domingos.
Una scuola in cemento con due grandi sale e con annessa casa dei
professori-catechisti.
Tutta la missione dal punto di vista scolastico era divisa in sei zone. Ognuna
aveva una scuola centrale dove confluivano i migliori studenti della quarta
classe (circa 200 all’anno), corrispondente all’ultimo anno della scuola elementare.
Nella scuola centrale insegnavano due professori, i migliori della squadra,
per preparare bene gli alunni agli esami finali. In Morrumbala, un distretto di
circa 13 000 km quadrati con, allora, più di 350 000 abitanti, Pro aveva creato
una fitta rete scolastica: una sessantina di scuole, o forse molto di più. I professori,
secondo l’Accordo Missionario tra Stato portoghese e Chiesa, erano anche
catechisti e le scuole a loro volta erano scuole-cappelle.
I professori-catechisti erano i nodi della fitta ragnatela di presenza, di sviluppo
e di evangelizzazione. Pro aveva interpretato e organizzato bene questo
ruolo di “espansione” sociale e cristiana della missione.
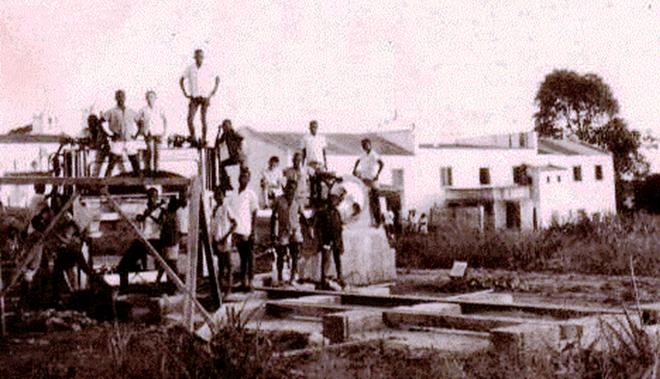
Procedendo più avanti: «Qui, in questa foresta, abbiamo l’autorizzazione a
tagliare i tronchi per fornire la segheria e la falegnameria della missione. Ecco il
vecchio trattore (non aveva neppure un pezzo di carrozzeria: solo motore, ruote
e sedile!) che serve per trascinare i tronchi. Questa squadra è specializzata in
questo mestiere. Tronchi di umbila, umbawa, chambiri, pau-rosa, chanfuta,
pau-preto, una foresta ricchissima. Il taglio è regolato per evitare la deforestazione,
ma è una miniera inesauribile, c’è da scegliere di meglio in meglio, di
tutto e di più. In missione si fa uno stoccaggio per l’essiccamento dei tronchi
che, poi, vengono segati. La falegnameria produce per noi, per le missioni e
per vendere il prodotto presso terzi. Qui trovano impiego i ragazzi che avendo
finito la quarta classe elementare e non potendo accedere alla scuola media della
missione, cominciano l’apprendistato, una sorta di scuola di arti e mestieri
per ogni specializzazione nell’arte della falegnameria. Solo così si creano nuovi
maestri che conoscono un mestiere».
Dopo qualche chilometro:
«Qui abita un amico: Chapotoka. Un bianco. I neri lo chiamano così perché
è zoppo, ma in questa parola c’è anche un po’ di odio per lui perché si arrabbia,
grida, sfrutta, minaccia, insulta. Fa i suoi interessi. Non è un missionario!
Attento a te! Bisogna essere calmi, pazienti, aperti alle necessità della gente.
Questa è povera gente! Ha bisogno di tutto, ha le sue tradizioni, le sue cerimonie.
Imbrogliano anche loro: chissà quante volte ti verranno a dire che gli è
morta la suocera o la nonna… È vero, a causa della poligamia possono averne
tante di suocere e di nonne, ma qualcuna la fanno morire più volte, perché
hanno bisogno di tempo! Loro non reggono i nostri ritmi e se tu non lo
“comprendi” e t’arrabbi, diventi un colonialista, ti fai odiare. Quando però ti
accorgi che ti imbrogliano, affronta i problemi con calma e pazienza, adattati
senza farti fregare e mantieni con fermezza i principi da non infrangere. Ti
vorranno bene e li porterai dove vuoi. E se ti vogliono bene, potrai anche gridare:
ti accetteranno, ti comprenderanno, ti perdoneranno!
Chapotoka non è così! Ma è nostro amico! Qualche suo figlio bianco o meticcio
studia da noi in missione. Ha un allevamento di circa 2000 buoi. Cosa
sono le 250 mucche della missione? Lui fa assistenza tecnica al nostro allevamento.
I ragazzi possono mangiare carne due volte la settimana e avere latte
ogni mattina. Cosa vuoi di meglio?».
E Pro… perdonava tutto!

Che tipo, Prosperino! Umano come un santo, focoso come un impresario,
comprensivo e tollerante, ingenuo e impulsivo, propositivo e conservatore, innovativo
ma senza fronzoli, acerbo, essenziale, mezzo dittatore e democratico
populista, amico disinteressato e calcolatore, generoso e anche un po’ geloso…
insomma “un buon cristiano”, un cappuccino!
E alla gente, agli operai piaceva così, anche perché certe cose troppo ben assestate,
pulite, organizzate… erano lontane dai loro orizzonti! Forse si era “acculturato”
o forse era proprio così. E così andava bene!
Cammina, cammina… «Fermiamoci […] Visitiamo questa o quella scuola
[…] Salutiamo l’amico […] Andiamo a vedere come va la vita del tale venuto
da poco dal Portogallo perché i suoi compatrioti non lo hanno accettato…». E
intanto caricava l’ennesimo passeggero che chiedeva boleia (fare l’autostop)
«Fermiamoci, deve scendere quella signora col bambino…»: la sua era la jeep
del buon samaritano o del cireneo che caricava tutti e tutte le cose! E si ricordava
puntualmente dove scendevano, prima che bussassero sul capò!
Breve pausa a Mopeia, la sua prima missione, per salutare i frati. «Mopeia
non cresce, vive pigramente, la sua storia è lenta. La gente dorme, non reagisce.
Mi dispiace. Mopeia mi ha fatto sognare, ma non risponde. Andiamo via!».

Finalmente a Luabo: febbraio 1972
A Luabo trovammo fra Giuseppe Gaudioso da Mola di Bari, un ex sottufficiale
di marina, prigioniero in Francia durante la seconda guerra mondiale, frate
dal 1949. Missionario di lungo corso, era arrivato in Mozambico col primo
gruppo di missionari cappuccini pugliesi il 4 maggio 1951. Venti anni di missione
alle spalle. Venti anni di eroismo. Non era un sacerdote, era un fratello
religioso, che non aveva studiato molto, ma la vita lo aveva reso saggio e il suo
spiccato senso pratico lo rendeva utile alla missione e servizievole nella vita fraterna.
Pro era contento di essere arrivato a casa. Con fra Giuseppe aveva uno strano
rapporto di empatia ma anche di attenzione speciale. Giuseppe non aveva
peli sulla lingua e le sue osservazioni erano acute e perspicaci. Pro lo ascoltava.
Sia l’uno sia l’altro erano abituati alla lotta, ad affrontare di petto i problemi;
su molte cose non erano d’accordo e il confronto era aperto e serrato, rispettoso
e genuino. Ma in fondo li legava una stima reciproca che diventava amicizia
piena di attenzioni vicendevoli.
Venne l’ora del pranzo. Era un pranzo con i fiocchi, che solo fra Giuseppe
sapeva preparare per ricevere per la prima volta in casa il nuovo superiore della
missione e un nuovo confratello appena arrivato dall’Italia.
Un pranzo sonoro, ricco di ilarità e di immediata comunicazione.
Mi meravigliava sempre di più notare che Pro era capacissimo di passare da
un momento di serio confronto ad un altro di giocosità e di facezia!
Che tipo!
Pro era quello che si direbbe “una buona forchetta”. Mangiava di tutto,
con appetito e con gusto: a tavola dava soddisfazione! Era capace, con una impertinenza
da bambino, di irritare fra Giuseppe, dando giudizi sulla sua cucina
e un voto a ogni piatto, alla quantità e qualità. Se riusciva a far saltare la pazienza
di fra Giuseppe, raggiungeva il culmine del gusto, finendo in una risata
fragorosa che rimetteva a posto ogni cosa!
Nel pomeriggio avemmo un incontro di riflessione insieme con fra Fedele,
altro componente della fraternità e primo consigliere del gruppo dirigente della
missione, sul progetto nuovo di missione da proporre ai frati nella lettera
programmatica per il prossimo triennio.

Pro gettava giù tumultuosamente le sue idee che venivano fuori un po’ disordinate,
ma secondo una sua coerenza logica a cui era difficile tenere il passo:
il fondo comune, (una sorta di cassa in cui sarebbe entrata ogni offerta); la
complementarietà delle missioni (ogni missione doveva trovare il suo specifico
campo d’azione più adatto all’ambiente, per sviluppare progetti che poi avrebbero
potuto essere utili anche alle altre missioni); l’evangelizzazione non più
come annuncio astratto e neppure come impegno del singolo missionario, ma
come azione di tutta la fraternità; la necessità per il missionario di studiare e
parlare le lingue bantu.
Alla fine, Prosperino si rese conto che era necessario mettere per iscritto
quanto aveva in cuore e in testa; poi sarebbe stato più facile organizzare le idee
in una proposta dinamica e partecipata.
Nacque in quel momento un metodo di confronto delle idee, di coinvolgimento
dinamico, di partecipazione, che Pro curava in forma quasi cocciuta e
sistematica per lo sviluppo dei progetti, delle proposte innovative e per la realizzazione
comunitaria delle stesse.
In qualche modo tutti entravano e si ritrovavano nel programma con uno
stile partecipato delle decisioni che non raramente portava a un confronto vivace
(Pro non era affatto un carattere accomodante!), con un percorso lungo e
lento, ma sicuro e coinvolgente.
La sua intelligenza vivace e la sua dialettica, spesso stringenti, conducevano
il gruppo ad accettare scelte e comportamenti che in breve influenzarono non
solo il nostro stile di vita, ma anche quello degli altri gruppi missionari e della
stessa diocesi.

Questa sua maniera di proporre e spingere le idee gli valse il soprannome di
“caterpillar” oppure di “proposta democratica … alla quale non si poteva dire
di no”!
Davanti a queste battute di noi giovani frati, suoi collaboratori, Pro scoppiava
in una risata sonora e contenta perché, in fondo, si ritrovava in questo
giudizio e sapeva bene di essere un leader e un trascinatore.
Spesso, questo suo modo di essere gli faceva prendere cantonate e gli faceva
sbattere il naso contro il muro, causandogli dispiaceri, malintesi, disagi e sofferenza,
e anche antipatie e sospetti.
Ma la grandezza del suo carattere era che al momento opportuno sapeva
mettersi in discussione, rifletteva, ritornava al confronto e all’ascolto. Non raramente,
anche se con molta fatica, ritirava le sue proposte e sapeva chiedere
scusa se la foga del confronto lo aveva portato a “trascurare le ragioni altrui”.
Questa risorsa umana e cristiana lo rendeva amico sincero e schietto, un
frate umile e dignitoso, un cappuccino coraggioso, un sacerdote forte e dolce,
aspro e misericordioso.
